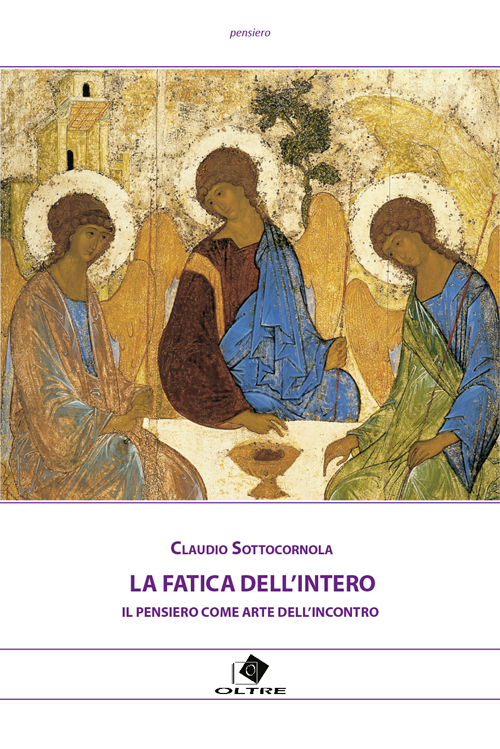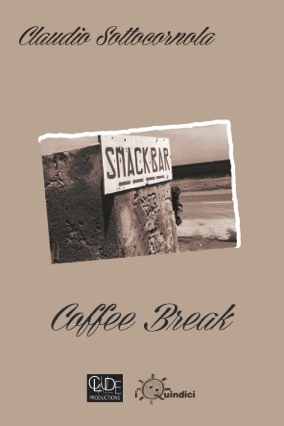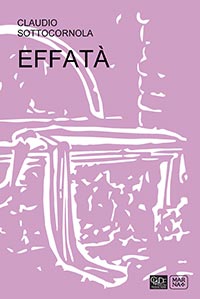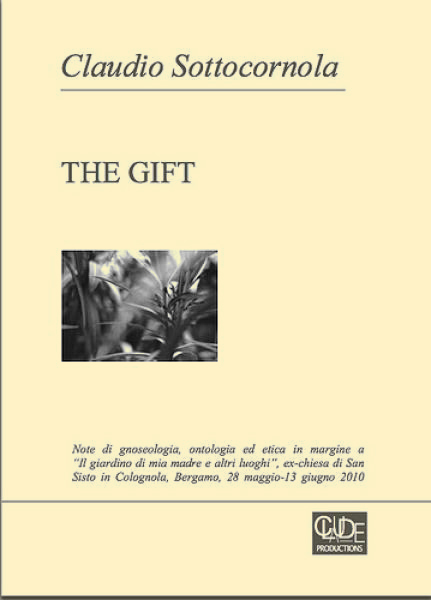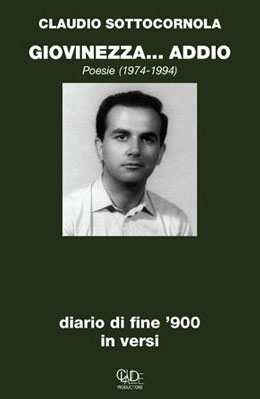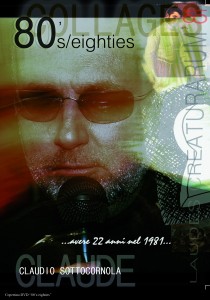Covid-19
(Anteprima da C. Sottocornola, Post Scriptum in “Parole Buone”,
Marna / Ebook in uscita, giugno 2020)
![]()
Mi sono chiesto anche, a fronte dell’inevitabile ritardo accumulato nella pubblicazione a causa dell’universale lockdown di questi giorni, se il suo contenuto e la sua forma avessero ancora ragion d’essere nella mutata situazione prodotta dalle terribili conseguenze dell’emergenza, nella fattispecie le migliaia di morti che hanno funestato la vita del nostro Paese e del pianeta intero, ma in particolare – vorrei quasi dire – della Lombardia e della città di Bergamo, dove abito, ove le immagini dei camion militari, che attraversano di notte Via Borgo Palazzo per smistare le salme che non possono più essere contenute in città nei forni crematori di mezza Italia, hanno fatto il giro del mondo. Quando si assiste a un’ecatombe, a una grande e sproporzionata tragedia collettiva – una guerra, una grande carestia, un contagio devastante – si apprende a relativizzare i tradizionali punti di riferimento, le anguste misure del giudizio abituale, e lo scenario del reale si allarga sino a rendere ininfluente, irrisorio, quasi imbarazzante ciò che prima appariva in primo piano e fondamentale. La grandezza e miseria della nostra condizione si appalesa, come voleva Pascal.
Ho dunque nuovamente sfogliato queste pagine e mi sono accorto che – sì – possono ancora essere lette, anche nell’orizzonte – e nella luce – di un nuovo inizio, di una disposizione alla speranza cui non venga però meno la necessaria lucidità nel decifrare segni, eventi, responsabilità. Ecco perché le “parole buone” che ho cercato di pronunciare in questo libro mi appaiono ancora leggibili, se pur precedenti la grande tragedia che ha attraversato le nostre terre e la nostra gente, e forse mi appaiono leggibili perché il bene che vorrebbero esprimere – per citare il titolo di un’illuminante opera del teologo Luigi Maria Epicoco (che a sua volta si ispira a Bernanos) – è “Sale, non miele”, vale a dire invito alla consapevolezza e, in questa, all’impegno, piuttosto che a una quiescente accettazione del dato.
Del resto, uno degli effetti più evidenti di questa emergenza è stato proprio quello di renderci consapevoli della bellezza di ciò che è – abitualmente, quotidianamente, banalmente – in quella “normalità” che andiamo oggi tutti rimpiangendo e invocando, e che abbiamo invece ignorato – o peggio, maledetto – quando attraversava i nostri giorni dove noi sapevamo vedere solo routine e non splendore. Oggi, che guardiamo il sole dalle finestre chiuse, sentiamo le rare voci umane che provengono dalla strada quasi sempre deserta con sorpresa e ricordiamo l’ultimo banchetto con nostalgia, oggi stiamo imparando che la nostra colpa è stata di non dire grazie a ciò che è e, pertanto, di non riconoscerne la smisurata grandezza.
C’è però una spiegazione che aiuta a comprendere ciò, specialmente nel nostro tempo, una ragione profonda, che senz’altro è alimentata dalla ottusità e cecità della mente e – più ancora – del cuore umano (che la fede chiama “peccato”), ma anche si alimenta a quelle “strutture”, come indicava papa Giovanni Paolo II, che tale ottusità, cecità o “peccato” finiscono con l’incarnare al punto da suscitare una sorta di replicazione e reiterazione indefinita della colpa, senza quasi che i singoli più si avvedano della stessa, quasi determinati dalla menzogna e dall’opacità che avvolgono ogni cosa, di molto restringendo gli spazi della libertà personale.
E io chiamerei questa colpa del mondo contemporaneo con un nome che a prima vista affascina e coinvolge, ma che cela in sé pericoli enormi per la vita, la sua profonda bellezza nascosta, il suo equilibrio. Chiamerei questa colpa: efficienza. Certo, lo so, non è l’efficienza in sé ad essere una colpa, ma l’efficientismo che la porta a diventare un idolo e, nell’attuale contesto socio-economico, un postulato utile al perpetuarsi di un sistema spesso ingiusto, che immola sull’altare del profitto le vite di milioni di esseri umani che, se appartengono – come accade in questo profondo Nord dell’Italia – a un contesto benestante, funzionante e altamente produttivo, nemmeno si avvedono dell’inganno, e con orgoglio procedono entro il perimetro di una prassi quotidiana che allontana sempre più dalla profondità delle relazioni, dalla capacità di assaporare la vita, dalla lucidità e armonia di mente e corpo, da un’esistenza davvero “umana”.
I giornali, le televisioni, il web hanno parlato e scritto, in questi giorni, delle drammatiche e, per certi versi, inspiegabili dimensioni che l’epidemia ha assunto in Lombardia e, in particolare, nella provincia di Bergamo, diventata quasi l’immagine più eloquente della sua più grave manifestazione di fronte al mondo. Inchieste giornalistiche e giudiziarie si stanno incaricando di far luce sulla questione ma, senza addentrarci in un terreno che non è di queste riflessioni, la constatazione che è sotto gli occhi di tutti riguarda l’omissione delle autorità pubbliche nel delimitare tempestivamente in Val Seriana, in particolare ad Alzano Lombardo e Nembro, spaventosi focolai di contagio, una “zona rossa” che avrebbe senz’altro limitato in modo enorme il numero dei morti che si sarebbero invece successivamente contati. Questo, a differenza che altrove, non è mai stato fatto: il risultato è che altrove il contagio è stato delimitato e le vittime anche, mentre da noi i morti hanno occupato coi loro necrologi le pagine del giornale locale come non era mai accaduto nella Storia, neanche durante le due guerre mondiali.
Non mi sarei dilungato in una narrazione che può sembrare terribilmente drammatica ma divagante rispetto alla natura programmatica di questo scritto se non avessi come scopo quello di additare le ragioni che – a detta di tutti gli osservatori informati del territorio – sono state all’origine di questa grave omissione, che ha poi determinato il diffondersi esponenziale dell’epidemia a livello locale. E tali ragioni sono vistosamente economiche, in quanto la Val Seriana, in provincia di Bergamo, è un’area altamente e fittamente industrializzata, con realtà i cui interessi sono di portata mondiale e dunque imprescindibili a livello nazionale. Non entrerò nelle ricostruzioni che vorrebbero Confindustria esercitare pressing su Governo o Regione per impedire la dichiarazione di una “zona rossa” in loco, ma rimando chiunque ad una personale ricerca fra stampa, web e tv (per tutti, consiglio la puntata del 6 aprile 2020 di “Report”, attualmente su RaiPlay, quasi interamente dedicata al caso-Bergamo).
“Ho scoperto che non lavoro per vivere ma vivo per lavorare e quindi sono sacrificabile”, dichiara in proposito un operaio della Val Seriana citato in un’intervista del 25 marzo 2020, apparsa su “Gli Stati generali”. E questo ci riporta al nostro tema, un efficientismo tecnologico e tecnicistico, idolatrato dalle due forme di materialismo dominante, quello del tardo capitalismo selvaggio e quello del vecchio ma culturalmente ancora pervasivo materialismo di ispirazione marxiana, spesso ormai sinergici a una medesima visione pratico-operativa del reale. E il grado che si occupa nell’ingranaggio che permette all’economia di funzionare determina il grado ontologico della nostra dignità: i tamponi, garanzia e tutela rispetto alla nostra condizione di salute in tempi di coronavirus, sono possibili, per esempio, a personaggi pubblici, calciatori, giornalisti di grido, politici di livello nazionale e, più in generale, a chi riveste posizioni di potere, mentre risultano impossibili ad anziani, preti, medici di base e insegnanti che, a breve (e parlo per esperienza personale) dovrebbero rientrare a scuola per gli esami di maturità, anche nella mia area ipercolpita dalla pandemia, senza alcuna tutela medico-sanitaria rispetto alla possibilità che siano positivi o meno al virus e, considerando l’età spesso over 55 di molti, con grave pericolo per la promiscuità dei contatti che in tali giorni essi saranno costretti a interfacciare.
A fronte della palese ingiustizia di questo sacrifico della vita all’efficienza, alla produzione e, più in generale, all’economia, la politica contemporanea, quella italiana per diverse ragioni storiche ma, più in generale, quella dell’Occidente e dell’Europa in particolare (erede ormai infedele della tradizione nobile e alta della antica polis), impara la splendida formalizzazione dell’esistente, ancorché eventualmente aberrante, in strutture linguisticamente ineccepibili e protocolli algidamente coerenti entro un orizzonte ove le preoccupazioni di sistema disattendono le aspettative, le speranze e, più in generale, le prospettive della vita che urge, con la sua sostanzialità, il suo calore, la sua voglia di sopravvivere al male.
E forse questo è il male maggiore, di cui la Sanità malata in cui viviamo è metafora e simbolo: l’assenza di cura e l’ipertrofia della prestazione. Oggi tu vai dove vuoi e ti sottoponi agli esami medici più sofisticati, ma il tuo medico di base non sa più chi sei, e quando stai male sei solo, il territorio è deserto e, al massimo, una voce preregistrata ti seleziona un operatore contrassegnato da un numero, che registra la tua telefonata a scopi di autotutela legale. E tu sei ancora più solo, e magari temi di avere il coronavirus, ma finché non arrivi alla Fase 3, quella della più assoluta gravità, nessuno, tranne – se li hai – i tuoi cari, si prenderà cura di te, nessuno cercherà di salvarti. Prendersi cura è un’altra delle esperienze – insieme al ringraziare – che questa pandemia ci dovrebbe reinsegnare.
Ma ne saremo capaci?
Rivado col ricordo alla perdita di mia mamma, avvenuta nel 2003 sempre a Bergamo, in circostanze che ritengo di poter riferire ad una grave situazione di malasanità. Ritardo colpevole nella diagnosi da parte del medico curante, infinite ore di attesa al pronto soccorso, destinazione a un reparto deserto di medici e infermieri nel fine settimana, somministrazione di un farmaco che le procurava gravi reazioni allergiche senza che si pervenisse a una sospensione, nonostante la segnalazione dei figli al personale, interruzione del sistema di allarme per non essere disturbati… L’indifferenza, a trapasso avvenuto, con il banale invito ad andarcene, tanto era tutto finito… E le indicazioni dei medici legali che – sì – avevamo molti indizi relativi a probabili errori od omissioni, ma non prove, quasi impossibili da reperire quando l’ammalato è un anziano con varie patologie che – come accaduto per questa epidemia di coronavirus – sembrano giustificare qualsiasi epilogo e deresponsabilizzare l’istituzione dal prenderselo effettivamente in carica con un atteggiamento di attenzione e di cura e non con cinico attendismo sull’evolversi di un caso, che difficilmente potrà riservare sorprese legali ai medici, che le temono invece nel caso di pazienti giovani e sani. Anche nel caso di mia madre sono stati applicati anonimi protocolli nella assenza di una condizione di reale cura e attenzione per la persona, anzi, di sostanziale abbandono, come è accaduto nell’occasione di questa pandemia, dove pochi medici, vittime ed eroi, sono stati lasciati soli a fronteggiare, negli ospedali e nelle case di ricovero, la prima linea di un territorio desertificato dalla medicina di base, e cioè da una adeguata rete di relazioni e di protezioni sociali e sanitarie, venute meno sempre di più con il diffondersi e radicarsi di una aberrante idea di medicina come prestazione tecnica, talvolta anche redditizia, cui corrispondono numeri e statistiche, non persone e relazioni.
Quando mancò mia madre, dopo aver verificato l’impossibilità di ottenere una qualche forma di giustizia a livello istituzionale, ho maturato l’intenzione profonda di celebrare la sacrale dignità, unicità e bellezza della sua persona – contro quella pratica spersonalizzante e annientante della malattia, e quella cecità anche di fronte alla morte avvertita sul piano delle istituzioni – con una ricerca, che è poi diventata una mostra fotografica itinerante e dvd, “Il giardino di mia madre e altri luoghi” (CLD), in cui ho voluto proprio ispirarmi al “giardino”, piccolo appezzamento di terreno che la mamma amava coltivare, come luogo e metafora della “cura”, come atteggiamento prevalente che ella ha sempre manifestato verso gli altri e il mondo, e che mi è parso così radicalmente negato e, direi, oltraggiato, dall’istituzione medica e ospedaliera di allora. E che oggi rivedo, non certo nei medici in prima linea, ma nell’istituzione pubblica che non ha tempo e soldi per effettuare tamponi ad anziani, medici di base, preti in prima linea, operai e insegnanti, che rinuncia all’istituzione di “zone rosse” quando gli interessi economici lo sconsiglino e che abbandona le RSA senza presidi, aiuti e protocolli adeguati, permettendo, ad esempio, un’ecatombe lombarda (si parla di 6000 morti effettivi), che non potrà non essere raccontata nei testi di Storia, e che io spero rechi anche indicazioni chiare circa le responsabilità pubbliche che ovviamente si cercherà invece di tacere.
Perché nella Storia quella “banalità del male” che Hannah Arendt attribuiva agli aguzzini nazisti, visti come grigi burocrati e tecnici amministrativi più che demoni e mostri, si ripete ancor oggi nella società efficiente che non ha più spazi per la cura e le relazioni umane, mentre idolatra la prestazione e il profitto, ove coscienze crasse producono malattia e morte semplicemente applicando freddi protocolli di indifferenza, per la quale, ad esempio, le vite degli anziani contano talmente poco da non meritare assistenza urgente, presidi adeguati, tutele della fragilità, cura del dettaglio e insieme della sostanza, ma anzi risultano inessenziali e talvolta persino disfunzionali alla efficienza del sistema, e dunque vengono lasciate morire, talvolta con gli eroi (infermiere, medici, familiari, ecc.) che perseverano nella loro cura contro ogni evidenza e contro al mondo. E c’è anche – Dio non voglia – chi ha parlato di probabili, latenti e occulte pratiche eutanasiche, che comunque vanno conquistando l’Occidente…
Non so dunque, come recita il Manzoni nella morte di Adelchi, se nella Storia “non resta che far torto, o patirlo”, oppure, sempre come scrive lo stesso Manzoni nelle ultime righe dei “Promessi Sposi”, se “i guai… quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore…”, ma credo che ambedue le teorie siano sostenibili e possano stare insieme, coesistere nello sforzo di nutrire il realismo e la speranza, anche e soprattutto in questi tempi bui.
C’è però che la mia tarda maturità mi sta regalando un senso di sempre maggior affinità, empatia e assonanza con quanti la nostra civiltà – come va ripetendo Papa Francesco – considera “scarto”, e che si possono rubricare sotto la varia dizione di barboni, emarginati, drogati, carcerati, immigrati, portatori di handicap, nullafacenti e giovani disoccupati, ma soprattutto anziani, ammalati, persone sole e – con questa guerra Covid-19 – in prima linea e senza difese. Perché constato sempre di più che il deprecabile tratto della superbia evangelica non si riferisce tanto alla posizione – più o meno di prestigio – che si occupa, ma a come la si occupa e – dunque – mi rendo conto che, a volte, basta un piccolo ruolo, una minuscola funzione, una supposta autorità, a generare in chi la esprime quella “banalità del male” che diventa cieca indifferenza, latente ostilità, quasi criminale attitudine alla soppressione dell’altro, quando questi ci interpella e provoca ad andare oltre, in direzione della vita. Mi accorgo allora che chi un ruolo non ha è libero, è illuminato, è spontaneo come un bambino e sapiente come un vecchio, ha il profumo del cielo e nessuno può trattenerlo.
E magari un incrocio di strada, una corsia d’ospedale, una cella angusta sono il luogo di una appartenenza alla vita e alla sua bellezza che nessuno scranno istituzionale, nessuna seggiola amministrativa, nessun trono mediatico potrà mai lontanamente eguagliare. È sempre la vecchia storia del povero Lazzaro e del ricco Epulone, nella quale: “… Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua… […] Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi” (Lc 16, 22-26).
Chi si disseterà alla fonte della vita? È evidente che la sete coltivata nelle prove e nell’indigenza costruisce un destino di attesa, di speranza, di dipendenza e relazione, che nessuna ricchezza, e soprattutto nessuna funzione (il potere come decisionalità è sempre stato – ed oggi più che mai – la più ambita delle ricchezze) potrà mai lontanamente eguagliare. Dunque io credo che i morti di Covid-19 sacrificati dall’economia sul territorio siano ora “nel seno di Abramo”, e non voglio nemmeno pensare al destino di colpa – che andrà dolorosamente elaborato – di quanti ce li hanno precocemente mandati.
E so che queste vittime sacrificali, per lo più colpevoli di essere vecchi, fragili e indifesi, hanno lasciato dietro di sé una scia di bellezza e di rimpianto, una memoria condivisa – magari da pochi ma sinceri affetti – che non passerà, valori luminosi che questa Covid-19 ci ha insegnato – suo malgrado – a riscoprire. Hanno lasciato un mondo, un giardino interiore che ciascuno ha coltivato e che ora sboccia per l’eternità e profumerà per sempre. Lo crediamo, per i nostri cari, per le vittime innocenti del Coronavirus e della incuria umana.
Alla faccia di quel metadone che sono i buoni sentimenti ai saldi che i media ci propinano, e che vorrebbero ci dimenticassimo della “banalità del male”.
fine aprile-primi di maggio 2020