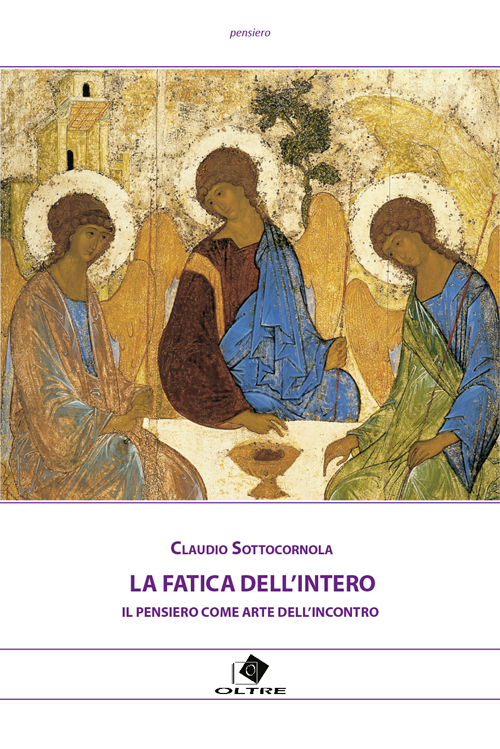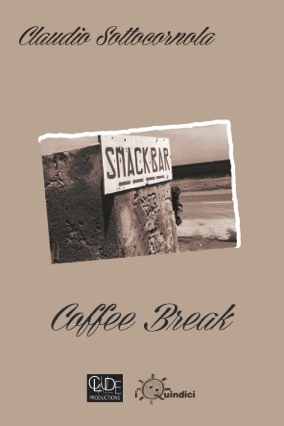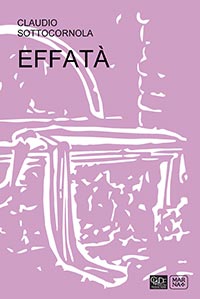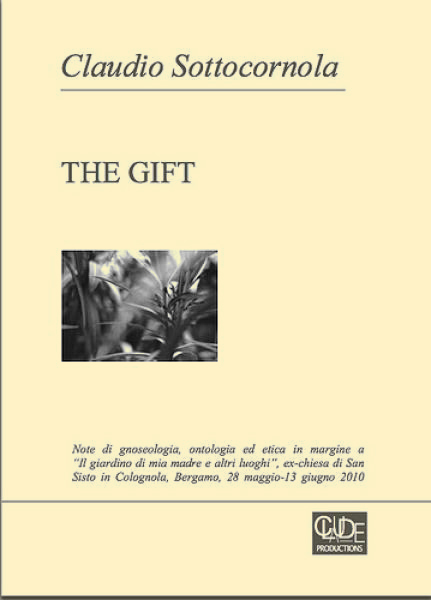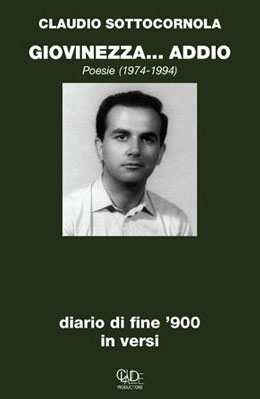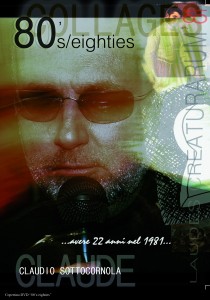Riflessione in occasione delle imminenti elezioni politiche italiane, settembre 2022
di Claudio Sottocornola

Sono stato studente di liceo nei gloriosi anni ’70, in un contesto dove il dibattito seguito al ’68 era intenso e vivace e, come ho scritto, per esempio in “Parole buone” (Marna, 2020), ritengo che esso abbia prodotto risultati nel complesso stimolanti rispetto ai temi della scuola e della cultura, della società e dei diritti, delle stesse relazioni fra persone e della autorealizzazione. Soprattutto – lo sappiamo – erano anni in cui ci si proiettava tutti verso un altro mondo possibile, eravamo abitati dall’utopia e da un desiderio, probabilmente espresso in modo maldestro, di trascendenza e di altrove. Non sono quindi fra i critici radicali di quel tempo, anche se ritengo che avesse in sé la grave contraddizione di ambire a realizzare un processo di liberazione collettiva, senza avere una adeguata nozione di libertà, ovvero senza saperla in alcun modo fondare, se si escludono alcune semplificazioni ideologiche dell’epoca, il che spiega la deriva adulta del movimento entro una concezione, in fondo, borghese di libertà, riassumibile in un generico “fa’ un po’ come credi…” (per esempio, nell’educazione dei figli).
Eppure – lo confesso – la mia disaffezione per la politica nasce proprio da quegli anni. Ero uno studente motivato e pieni di interessi (amavo la poesia, la filosofia, il cinema d’autore, vinsi una borsa di studio per gli Stati Uniti ed una, più breve, per la Spagna, mi diplomai col massimo dei voti…) eppure, quando partecipavo alle assemblee d’istituto presso il Palazzetto dello Sport della mia città, gremito come non mai, avvertivo lo svolgersi della medesima liturgia ogni volta, con una sequenza di studenti che reiteravano un messaggio conformista e convenzionale rispetto alla vulgata marxiana dell’epoca, non privo di spunti e suggestioni ma del tutto univoco e privo di contraddittorio, se si eccettua qualche timido, e altrettanto maldestro, tentativo di intervento da parte di giovani ciellini o moderati, rapidamente tacitati da fischi e disapprovazione generale, mentre persisteva il tabù per cui esponenti giudicati di destra e bollati come fascisti erano fisicamente impediti di accedere al dibattito e, se in modo fortuito lo facevano, era il finimondo, talché io confesso che non ho mai potuto realmente ascoltarne uno e rendermi conto delle eventuali nefandezze che avrebbe pronunciato, dovendo limitarmi a fidarmi della censura preventiva imposta a tutti noi. Essendo sensibile a tutti i temi che venivano presentati – in testa quello di una umanizzazione della cultura e della sua trasmissione – soffrivo di una sorta di disagio legata alla impossibilità di partecipare attivamente al dibattito, proponendo una visione più complessa e articolata, anche più inclusiva e tollerante, che non sarebbe stata capita e accettata. Ero interessato alla teoria marxista, ma dal punto di vista speculativo, ed ero senz’altro più attratto dalle tematiche dell’esistenzialismo francese o del decadentismo europeo in genere, come pure dalla domanda di senso che investiva ordini diversi da quelli del materialismo storico dialettico. Come avrei potuto far passare ciò in una condizione di dibattito pubblico così vettorializzato e omologato?
Una conferma di questa impossibilità mi venne partecipando a una riunione pomeridiana del collettivo della scuola, su invito di uno studente coinvolto, che avrebbe dovuto preparare la successiva assemblea d’istituto. Ebbene, in tale frangente, mi accorsi che i partecipanti elaboravano una strategia di monopolizzazione della futura assemblea, pianificando un suo inizio con massiccia iscrizione a parlare dei propri adepti, in modo tale da rendere o impossibile o irrisorio e tardivo l’intervento di studenti indipendenti e potenzialmente non ortodossi, ovviamente da fischiare e zittire in tutti i modi, così da rendere ininfluente il loro intervento. L’iniquità della procedura, che evidentemente era ritenuta però da quegli studenti politicamente legittima, era talmente evidente che proprio lo studente che mi aveva invitato protestò con i compagni dichiarando che non era opportuno pronunciarsi in modo così esplicito con ospiti che partecipavano a tale collettivo per la prima volta (per quel che mi riguarda, fu anche l’ultima).
E come potevamo noi cantare?, direbbe Salvatore Quasimodo. Mi fu in qualche modo da subito chiaro che non era possibile partecipare a quella sorta di messa cantata se non se ne condividevano integralmente i canti e, forse, quella fu la sede in cui compresi che in tale contesto fare politica o interessarsi attivamente ad essa voleva dire appartenenza cieca e totale, così come altrettanta appartenenza era richiesta per opporsi eventualmente ad essa. Per fortuna, cominciai ad appassionarmi più stabilmente alla filosofia e fu lì che trovai la libertà che andavo cercando, e di questo oggi sono grato, soprattutto di non aver fatto parte di congreghe e consorterie che mi avrebbero imprigionato, anche se non manco di rilevare che proprio tale appartenenza ha consentito in seguito a molti fra i suoi esponenti, raggiunta l’età adulta, di convertirsi a posizioni più moderate, entro la medesima area culturale e ideologica, e di occupare posizioni di prestigio nella vita pubblica, politica, culturale, economica e sociale, esattamente come allora occupavano le assemblee studentesche. Naturale leadership o mafia clientelare?
Dal canto mio sono sempre stato sensibile al fare, cose magari piccole, ma possibili senza compromessi vergognosi o abiure innominabili della complessità. Per esempio, proprio negli anni del liceo, esprimermi come rappresentante di classe o, in seguito, entro una commissione bibliotecaria o un consiglio pastorale, in un consiglio d’istituto nei primi anni di insegnamento, in gruppi di animazione del quartiere o di volontariato negli anni universitari, insomma nel fare politica come compartecipazione al territorio e alla comunità che lo abita. E resta inteso che la mia esperienza adulta come docente nei licei, insieme alla mia attività pubblica di espressione e scrittura, è stata il gesto politicamente più rilevante che penso di avere espresso. Ma, certamente, l’esperienza della politica trasmessami da quegli anni di liceo ha rappresentato per me una sorta di censura che mi ha impedito un accesso ad essa più attivo e radicale, perché avrei dovuto rinunciare a una complessità che il pensiero mi suggeriva ed il cuore mi attestava proprio come irrinunciabile.
Non andò molto diversamente negli anni dell’università, che frequentai a Milano. A seguito di alcuni scioperi del personale amministrativo alla Statale, che mi rendevano difficile formalizzare la mia eventuale iscrizione, decisi di scegliere l’Università Cattolica, dove, per il corso di laurea in Filosofia che intendevo seguire, erano presenti docenti storici di grande valore accademico, come Sofia Vanni Rovighi, Giovanni Reale, Virgilio Melchiorre, Gustavo Bontadini. Ma il parterre studentesco mi apparve, ancora una volta, caratterizzato da rigide appartenenze: da un lato, in posizione nettamente prevalente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, il gruppo degli studenti di CL, estremamente attivo ma anche troppo entusiasta nel proporre una adesione dal sapore quasi messianico alla propria visione spirituale e sociale, dall’altra una esigua minoranza di studenti dell’area FGCI che mostravano altrettanto integralismo anche se diversamente declinato. Ancora una volta, andai per la mia strada e non me ne pento.
Anni ’90 e personalizzazione della politica
Se considero che all’incirca verso la metà degli anni ’80 vi è stata la conclusione dei miei studi universitari, il servizio civile come obiettore di coscienza e l’inizio della mia attività di insegnamento, avverto che all’epoca forse l’aspetto che mi colpì in modo più rilevante rispetto al tema della responsabilità politica fu la riflessione antropologica e filosofica portata avanti dal pontefice di allora, Giovanni Paolo II, che aveva il pregio di coniugare pensiero classico, teologia e spiritualità cristiana, fenomenologia novecentesca e apertura ai saperi contemporanei, entro una visione globale di politica come servizio dell’uomo, senz’altro avvincente ma anche, per la prima volta nella mia esperienza, credibile rispetto a quella vocazione alta del fare politica che probabilmente andavo cercando, senza trovare modelli che vi corrispondessero. Purtroppo, la crisi della Prima Repubblica, con lo scoppio del fenomeno di tangentopoli e Mani Pulite, resa possibile dalla caduta del muro di Berlino del 1989 e dalla fine del mondo bipolare, inaugurò una nuova stagione politica in Italia che, al di là della sua necessità e, anche, di ricadute eventualmente di valore, produsse una tale personalizzazione della politica e la sua identificazione con leader iconici e cannibali rispetto alla articolazione di una vita politica del territorio e della comunità, da allontanare, ancora una volta, chi non volesse arruolarsi in un esercito ben ordinato al soldo di questo o quel capitano di ventura. E dunque, ancora una volta, mi segnalò una estraneità della mia esperienza a tale contesto, che andava accettata ed anzi coltivata. Sorvolo sul resto della storia perché, ad oggi, tale triste fenomeno si è semmai decuplicato, pur variando e moltiplicando a dismisura gli attori in gioco, trasformando la vita politica in un grande circo mediatico o, con linguaggio più contemporaneo, in un immenso reality show, ove le tifoserie si accaniscono e scontrano, entro un surreale paradigma pop-trash, divistico e spettacolare, nel quale il territorio con i sui abitanti, ridotti ormai a comparse che sfilano al seggio elettorale, è dimenticato, esattamente come accadeva alle città fantasma nel lontano West. Con tali premesse, quale il destino per chi della politica abbia nostalgia, nel solco, per esempio, di Platone, Aristotele e Kant?
Vorrei sottolineare che il pensiero dominante tende a presentarci la politica come un’attività svolta da alcuni specialisti ai quali dovremmo delegare la decisionalità pubblica con l’operazione periodica del voto, e ci presenta questa modalità quale alta e univoca, quasi che la politica si esaurisse per i più appunto in tale nobile operazione una tantum, peraltro dagli effetti molto limitatamente democratici se pensiamo alle attuali leggi elettorali, che comportano una dimensione compilatoria delle liste da parte delle segreterie dei partiti, tale per cui l’elettore si limita a ratificare il proprio cieco consenso a un menu politico che gli viene imposto e che egli deve ingoiare, fornendo in tal modo legittimità ai designati. Ora, il mainstream politico dominante in questo tardo capitalismo ci vuol far credere che la vera opzione politica stia nella scelta fra opposti schieramenti entro la modalità del voto, mentre la vera opzione politica sta proprio nell’elaborare una diversa concezione della politica, in cui il cittadino non sia chiamato ad essere politico solo in quell’episodico e troppo spesso effimero gesto, ma nella propria quotidianità, finalmente resa protagonistica e decisionale, partecipe ed efficacemente attiva. Cose brutte, che questo sistema economico tardo capitalistico non vuole, perché vede in esse l’annuncio della propria crisi.
Dalla politica del voto alla riscoperta della vita come soggetto politico
Penso infatti a quanto sia deprimente ascoltare da più parti il proposito di accedere al voto sì, ma tappandosi il naso (come voleva in altri tempi, peraltro più felici, Indro Montanelli), senza alcuna aspettativa o speranza per l’esito delle urne, per poi ritornare alla propria impolitica routine, segnata dall’ininfluenza della nostra vita non solo sui grandi destini collettivi ma – ahimè purtroppo – anche sul ristretto ambito territoriale e sociale di riferimento, dal quartiere alla città alla regione, e ancor più dalla siderale lontananza dei poteri pubblici, della loro burocrazia e amministrazione, con una sanità e una giustizia kafkiane. Tutti noi in Italia viviamo bene nello Stato finché lo ignoriamo, ma quando dobbiamo intercettarlo per ragioni di salute, istruzione, assistenza o giudiziarie, allora iniziano i guai, le sofferenze, le inutili e interminabili attese, i più assurdi paradossi e le più eclatanti contraddizioni. E nessuno crede ormai che una x sulla scheda elettorale possa cambiare radicalmente le cose, anche se vorrebbero convincerci del contrario, e noi ancora una volta, diligentemente, risponderemo alla chiamata recandoci al seggio.
A tal proposito, sono convinto tuttavia che il piccolo gesto del voto – anche se deprivato in gran parte di senso democratico dalla modalità di composizione delle liste, cui corrisponde, come si è detto, una semplice ratifica dell’elettore – abbia un senso compiuto. Se infatti mi trovo su un autobus e devo scegliere il conducente che mi porterà a destinazione, pur nella eventuale limitatezza delle opzioni, è mio dovere contribuire alla scelta del migliore possibile fra quelli disponibili, in modo da arrivare alla meta sano e salvo, senza incidenti. Ora, analogamente, in una comunità (sia pur anemica e inconsistente come la nostra) occorre stabilire chi dovrà prendere decisioni rilevanti in ordine al suo mantenimento e funzionamento, cosa che inciderà sulla vita reale di milioni di persone (pensiamo anche solo alle recenti esperienze di gestione della pandemia o, attualmente, all’immane problema del rincaro energetico generalizzato). Dunque votare significa assumersi questa responsabilità e, come dice spesso Papa Francesco a proposito dell’impegno sociale del credente, sporcarsi le mani con la realtà delle cose, nonché inevitabile, è anche giusto.
Negli ultimi anni ho però maturato, accanto a questa posizione, l’idea della eticità anche del non-voto. Mi accorgo, per esempio, che è ormai quasi impossibile condividere in toto un programma di partito. Accade infatti di condividerne alcuni punti e non altri, di avvertire empatia per qualche contenuto ma anche pesanti riserve per altri, oppure di nutrire scarsa fiducia in quel leader che dovrebbe esprimere al meglio le nostre idee e sincera ammirazione personale per chi ne propugna di diverse. Insomma, a fronte delle opposte e speculari difficoltà a scegliere, rischiamo di lasciarci morire come l’asino di Buridano che, posto fra due uguali porzioni di fieno alla medesima distanza, non sapendo in quale direzione andare, si lasciò morire d’inedia. Ritengo che tutte le difficoltà siano però superabili tranne – forse, ed è la ragione per cui reputo etico anche il non-voto – quella di una incompatibilità valoriale essenziale con punti programmatici che, anche diversi nelle diverse liste, attraverso il nostro voto finiremmo tuttavia con l’avallare. Anche in questo caso è però da considerare se l’astensione in virtù di tale riserva non possa tuttavia arrecare maggior danno alla comunità rispetto a un voto con riserva, qualora tale astensione venisse virtualmente estesa a un numero elevato di elettori, rischiando di delegittimare il conseguente responso delle urne e rendendo così del tutto ingovernabile un Paese, con ripercussioni più gravi per tutta la popolazione rispetto al rischio, che ho evocato, di avallare un’azione di governo in qualche parte distonica rispetto ai nostri convincimenti. Detto questo, ancora una volta, poiché una coscienza che si sforza di conseguire una retta formazione e informazione è sovrana nell’agire di conseguenza, essa potrà al limite decidere per il non-voto anche come espressione di impegno politico, qualora non possa fornire il proprio assenso ad alcun partito sulla scheda elettorale, in virtù della incompatibilità rilevata, e tuttavia dovrà poi inevitabilmente sottostare, almeno di fatto, al responso delle urne, che non avrà potuto concorrere a definire. Questo vale anche nel caso il non-voto segnali l’opzione più generale per una radicale alternativa di sistema, rispetto a quello politico corrente, che evidentemente, in tal caso, il non votante intende segnalare, probabilmente indifferente allo stesso risultato e alla leadership che ne seguirà.
Comunque sia, il mio auspicio è quello che ognuno si orienti responsabilmente almeno verso il male minore recandosi al seggio, consapevole tuttavia del carattere quasi di farsa che le procedure elettorali hanno finito col produrre nel nostro Paese, e ancor più della relativa ininfluenza della politica rispetto al grande potere economico internazionale. Ma, ancor più, ciò che ritengo essenziale per ognuno è relativizzare il gesto del voto rispetto alla presa di coscienza che il vero soggetto della politica sono le nostre vite, con le loro mozioni, desideri, azioni, impegni, progetti, sogni, e non il gesto elettorale, non la mera funzione di ratificare la presenza di un funzionario che ci rappresenti esonerandoci dalla responsabilità, ormai ignorata dai più, di prendersi cura e carico delle relazioni, della comunità e dei territori. Questa è la politica che abbiamo dimenticato, come profetizzava Marcuse, secondo il quale saremmo stati ben presto troppo pigri e viziati per sprecare energie nel tentativo di cambiare e migliorare le cose. È il diktat di questo tardo capitalismo, in fondo, corromperci attraverso il comfort (Poltronesofà, con la sua insopportabile e ammiccante pubblicità, ne è la metafora più eloquente), rendendoci docili e obbedienti al mercato, ai consumi, e alla soddisfazione dei bisogni mediante l’abbondanza delle merci.
La consapevolezza del sé e dell’altro, della consistenza ontologica del proprio essere e agire, dunque della sua risonanza politica
Insomma, ci siamo ormai abituati – e la pandemia da Covid ha, se possibile, esasperato tale esperienza – ad avvertire tutta l’ininfluenza delle nostre vite sull’andamento delle cose e, mentre i più languiscono tra una tv e un pc, uno smartphone e un breve soggiorno low cost, la politica si è fatta sempre più distante, deterritorializzata, è diventata mediatica e social, si è delegata ad altri per sopraggiunta incapacità congenita, e questi a volte sono stati migliori, come nel caso di Mario Draghi che, non a caso, è un uomo del fare, ma di un fare meditato e competente, al quale non si può certo rimproverare di avere una formazione economica se, con quella formazione economica, ha cerca di dare il meglio di sé per il Paese. Peccato che per trovare il meglio della politica si debba ormai uscire dalla politica…
Ma proprio il modello Draghi mi suggerisce una riflessione sulla necessità di recuperare per tutti una medesima attenzione a quel fare meditato che può costituire la differenza sul piano della efficacia politica. Ci hanno convinto, a forza di alimentare la nostra passività esistenziale attraverso consumi, comodità, serie tv e pagine facebook, che agire è inutile e improduttivo o, meglio, hanno dirottato tale desiderio d’azione in coazione al consumo, quasi che solo attraverso l’acquisizione di merci l’uomo possa riplasmare la propria vita. Politicamente hanno davvero trasformato l’uomo occidentale in un fantoccio ludico e vizioso, scoraggiando all’azione chiunque abbia ideali e indipendenza di giudizio, attraverso una silenziosa condanna alla invisibilità e alla marginalizzazione. Come lo schiavo che, nel mito platonico, ritornando nella caverna dopo essere stato esposto alla luce viene preso per pazzo e ucciso, o come il piccolo protagonista di “Giorno d’esame” di Henry Slesar che, troppo lucido e intelligente per il sistema distopico di una futura alienante società, viene soppresso dal sistema in quanto pericoloso.
Ma politicamente occorre proprio questo, il coraggio della marginalità, lo stesso che faceva vagare Pasolini fra il sottoproletariato urbano e le società arcaiche di culture extraeuropee alla ricerca di autenticità e vita vera, incontaminata e non corrotta da merci e consumi, che portava il grande Ermanno Olmi sulle rive del Po o nelle campagne bergamasche a ritrovare la poesia della semplicità e della appartenenza comunitaria, o ispirava don Lorenzo Milani nel Mugello a realizzare quella straordinaria e irripetibile esperienza che fu la Scuola di Barbiana per quei ragazzi di montagna. E se è vero che, per la maggior parte di noi, appare difficile compiere gesti profetici e radicali che incidano sul destino dei più, è tuttavia altrettanto certo che, come sostiene la sociologia dei micro-cambiamenti, singoli gesti individuali, all’apparenza insignificanti e ininfluenti, possono avere invece effetti imprevedibili, ben oltre il raggio della nostra azione. Pensiamo, ad esempio, quanto un insegnante possa influire sulla formazione dei suoi alunni, determinandone talvolta un successivo esito, positivo o negativo, sul piano professionale ma anche umano; a maggior ragione, immaginiamo quanto sia decisivo il ruolo di un genitore verso i figli, ma anche di un soggetto che, in una comunità o su un territorio, denunci un abuso o si impegni per un progetto solidale, di promozione e tutela ambientale o artistica. Voglio ricordare un piccolo episodio personale, che ritengo però emblematico. Qualche tempo fa, osservando l’incuria di una parte del cimitero ove sono seppelliti i miei cari, mi riproposi di fare qualcosa per tentare di rimediare a quello stato di cose. Incominciai con lo scrivere una mail all’ufficio cimiteriale del mio comune di residenza, alla quale ricevetti una risposta sommaria che non risolveva il problema. Insistetti e ne inviai un’altra, poi ebbi un contatto telefonico, poi altri ancora, e cercai di tenermi costantemente informato, avendo avuto la fortuna di incontrare un funzionario disponibile e attento, che a sua volta intercettò altri uffici dediti alla tutela dei monumenti cittadini. Ebbene, alcuni mesi dopo tale iniziativa, posso dire che qualche risultato è stato raggiunto: l’intonacatura di un muro lercio da anni, il ripristino di una soffittatura ormai cadente, la piantumazione di piante arboree in aiuole deserte da tempo, la collocazione di vasi con fiori sotto il monumento ai caduti delle due guerre mondiali. Non so se tutto questo è dipeso unicamente dal mio intervento, ma sono contento di averlo fatto, ed ho imparato che, a volte, occorre vincere una sorta di naturale ritrosia che ci fornisce alibi a iosa e intervenire per migliorare le cose. E potremmo continuare oltre, fra le pieghe di ciò che politico non appare a prima vista, ma lo è profondamente, come la visita a un anziano, a un malato, il sostegno a un povero o a un migrante, ecc. Queste sono situazioni nelle quali poi non solo si esercita un potere socialmente benefico, risanante e riparativo, ma attraverso la propria progettualità umana e sociale, si avverte anche una sorta di espansione del sé, non drogata e malata, come quella edonistico-consumistica, ma sana, solare e gioiosa, connessa all’esplicarsi delle nostre potenzialità più intime e della nostra essenza profonda, che è senz’altro un’essenza sociale e, dunque, in certo qual modo, politica.
Acquisire consapevolezza del sé e dell’altro, avvertire la consistenza ontologica del proprio essere e agire: è questa la prima istanza di riappropriazione politica che dobbiamo realizzare, magari iniziando con lo spegnere un televisore o un cellulare, parlandosi a tavola, telefonando a un parente anziano, uscendo per una passeggiata e ricominciando a salutare i vicini. Uscire dalla rappresentazione virtuale che, soprattutto attraverso i media, il sistema economico tardo capitalistico vuole farci introiettare e assimilare rispetto al sé e all’altro, e costruire rapporti e scelte che invece rispecchino altre logiche, altre esigenze, altri desideri, è il primo e forse l’unico passo fondamentale per riguadagnare l’anima. Quando avremo cessato di pensare e di pensarci secondo i paradigmi della attuale iconocrazia mondiale (mass media come riflesso del capitale internazionale e del suo potere acefalo e onnivoro), avremo forse iniziato a realizzare la nostra liberazione politica. A me piace chiamarla una emancipazione esistenziale che ci porterà ad avvertire tutta la forza e tutta la bellezza che ci attraversa, e che come una sorta di onda sonora o luminosa si propagherà attorno a noi generando un bene che andrà oltre noi stessi, sarà relazionale ma, per restare nel linguaggio politico, possiamo anche chiamarlo pubblico. E il sogno dell’utopia tornerà ad attraversare il nostro immaginario, che rifiorirà in una nuova primavera.